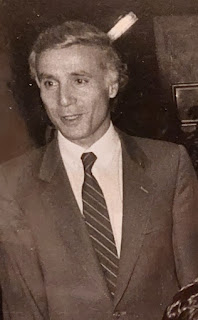HA APERTO LA STAGIONE LIRICA ENTUSIASMANDO IL PUBBLICO
FRANCO PRESICCI
 |
| Elio Greco e Guido Le Noci |
E allora tutti a guardarla, ad ammirarla, a bearsi di quella luce. Leo Muscato, regista e drammaturgo, studi di regia alla scuola d’arte “Paolo Grassi” di Milano, ha una bella carriera da mostrare. Tra opera e prosa. Dal 2001 ha portato in scena 30 composizioni liriche e altrettanti testi teatrali. Ha prodotto per il Teatro alla Scala, per il Petruzzelli, per il Maggio Musicale Fiorentino e per tanti altri templi anche all’estero, compreso il Greek National Opera. E naturalmente ha portato a casa molti riconoscimenti, tutti prestigiosi. Il più recente, in onore della sua strepitosa attività, il trentasettesimo “Mario Campus”, intitolato al giornalista che si prodigò per il Festival di Spoleto e il Festival della Valle d’Itria; un Premio ideato dal compianto Elio Greco, presidente di Fondazione Nuove Proposte, e oggi continuato dalla figlia Cinzia.
Durante la cerimonia di premiazione, nel Ridotto dei palchi Arturo Toscanini, alla Scala, il professor Francesco Lenoci, docente all’Università Cattolica di Milano, nella sua “laudatio”, ha tratteggiato icasticamente la personalità di Leo Muscato, la sua genialità artistica, l’impegno, la passione; e lo ha fatto con parole toccanti, anche ricordando il luogo di nascita, la culla del Maestro: Martina Franca, la città che custodisce gelosamente la bellezza che Dio le ha donato.
Lenoci, conferenziere di notevole valore, viaggiatore culturale infaticabile, ha tra l’altro cercato d’intercettare l’uomo oltre l’artista, il suo amore per la sua città d’origine, la città del sole, della luce, del ristoro. Il Premio Campus - ha detto - viene assegnato a personalità illustri, che danno sempre più valore alla cultura, offrendo opere che rimarranno e saranno celebrate dai posteri. E Leo Muscato, 51 anni, illumina il panorama culturale italiano e internazionale. E ha aggiunto: “Un tributo non solo al suo talento registico, ma anche alla sua capacità di raccontare storie che coniugano tradizione e innovazione”.
 |
| Muscato sotto il doppio busto |
Il Premio comprende un’opera pittorica di Manuel Campus e una mini-biblioteca di 50 volumi, che Leo Muscato ha donato ad un carcere, nella speranza che la lettura contribuisca alla rinascita umana dei detenuti e al loro reinserimento nella società.
La serata alla Scala, com’era prevedibile, rimarrà nella storia del Teatro. La scenografia dell’opera andata in scena, “La Forza del Destino” 2024 rappresenta le guerre, ma non per esaltarle, essendo la guerra, come afferma don Tonino Bello, “il più sacrilego dei peccati”; ma per condannarle, esecrarle. Infatti il soprano Anna Neprerbko alla fine canta: “Pace, pace, mio Dio”. E quel canto dovremmo ripeterlo tutti a gran voce contro tutti i conflitti in corso, che stanno portando feriti, morti, distruzioni di Paesi.
Per Leo Muscato l’opera dell’altra sera, che ha inaugurato la stagione 2024 del tempio della lirica, è stata l’affermazione della sua grandezza, del suo talento: un orgoglio per gli italiani e tutti i martinesi, non solo quelli presenti alla Scala per acclamarlo con grande entusiasmo, presenti Bruno Vespa, Milly Carlucci e tanti altri protagonisti dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria.
 |
| Ingresso al Piccolo Teatro |
Questo figlio della città dei trulli e del belcanto, della terra rossa e degli ulivi - la città benedetta da Dio, come disse tantissimi anni fa Alessandro Caroli presentando il suo libro, “Musica in Valle d’Itria”, sul Festival nato da una sua idea - ha inanellato un altro trionfo ai tanti già conseguiti. Come quello che contrassegnò il suo contributo al Festival della Valle d’Itria, uno dei momenti più esaltanti della musica lirica italiana. In occasione del cinquantesimo anniversario il regista e drammaturgo ha realizzato il documentario “L’Utopia della Valle”, opera in grado di far sfolgorare Martina, un gioiello, dando ancora più lustro al Festival, esaltato durante le presentazioni al Piccolo di Milano da Sergio Escobar, direttore del Teatro di via Rovello.
Muscato, che andando per il mondo, si porta appresso il cuore di Martina, appena sono esplose le luci della ribalta della Scala, ha offerto il ,capolavoro verdiano e la prova che il teatro, come diceva Paolo Grassi, “è il luogo dove si vede ciò che è invisibile agli occhi”. Il mondo intero si è emozionato, grazie a lui.
Ripercorrere l’itinerario artistico di Leo Muscato non è impresa da poco. E bisogna pur farlo, perché non tutti conoscono i grandissimi passi da lui compiuti. Nel 2007 l’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali gli ha assegnato il Premio della Critica come miglior regista teatrale; nel 2012 i critici musicali il Premio Abbiati come miglior regista d’opera; nel 2016 la Fondazione Verona per l’Arena gli ha assegnato l’International Opera Awards – Opera Star (oscar della lirica), come miglior regista … Una lista lunghissima anche di opere, da “Un ballo in maschera” al “Rigoletto”, dalla “Cenerentola” al “Barbiere di Siviglia”, al “Nabucco”, alla “Bohème”, estendendo sempre di più la sua popolarità. Inoltre, per tre anni (dal 2019 al 2022) è stato direttore artistico della Compagnia Teatrale di Luigi De Filippo. Del 2015 il suo documentario ”Geometrie Anarchiche”, prodotto da Fruit ADV, co-diretto da Laura Perini, con Vincenzo Mollica, Tullio Pericoli, Giobbe Covatta…
 |
| Lenoci e Leo Muscato |
I melomani sono in festa per il risultato delle prestazioni scaligeri di Leo Muscato, da prendere come modello, come esempio, ha detto un estimatore anziano, che pur volendo rimanere anonimo ha rivelato di essere in procinto di scrivere una biografia di Muscato. Starà già raccogliendo il materiale necessario. Ne ha da mietere.
 |
| La Scala |
Nato il 12 luglio del 1973, Muscato si trasferì nella Capitale per studiare Lettere e Filosofia e già quando era all’università gli si aprirono le porte del teatro, avviando un percorso sfavillante fra teatro, lirica, cinema e pedagogia teatrale. Un percorso ricco di eventi, date, consensi, trionfi, dirigendo 40 opere nei teatri più importanti e famosi del mondo (oltre alla Scala, il Teatro San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari), firmando la regia di oltre 30 testi teatrali, collaborando con istituzioni come il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Stabile di Genova.
Leo Muscato è l’emblema dell’impegno, del sacrificio, della determinatezza, della passione indispensabili per conseguire una meta sfavillante, come provano anche le numerose tesi di laurea presentate in tante università. In un comunicato si dice tra l’altro che il grande artista ha insegnato in istituzioni eccellenti, tra cui la Scuola Holden e i Dams di Torino, promuovendo “masterclass” “che esplorano le molteplici possibilità espressive del teatro e della lirica”.